Poeti russi. Versi dal fronte dello spaesamento
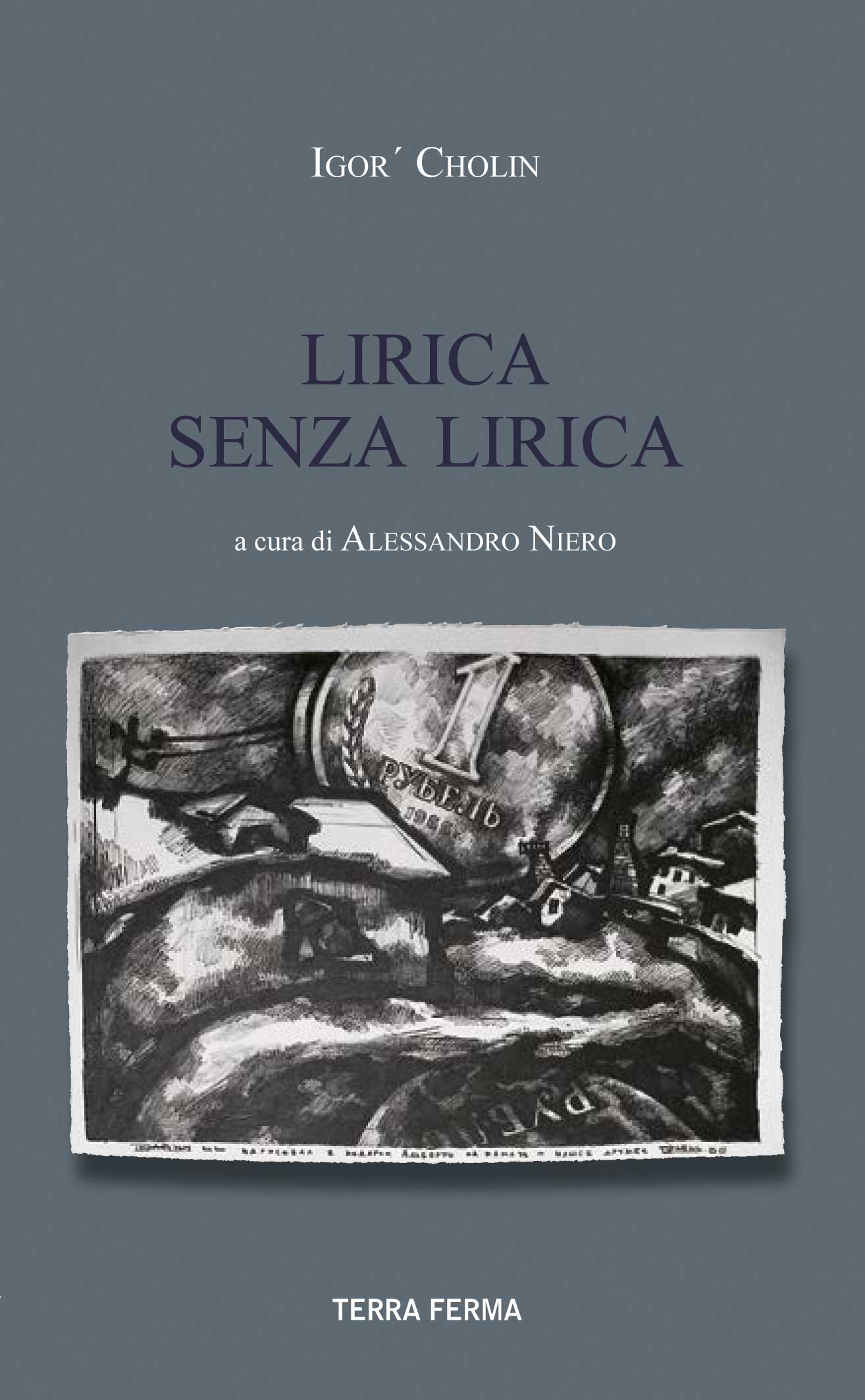
Da una parte l’emarginato volontario Igor’ Cholin, che non pubblicò nulla in vita, dall’altra l’«integrato» Boris Sluckij, macerato tra compromessi e rimorsi: due modi opposti di confronto con il potere sovietico Nelle pagine conclusive di Vita e destino Vasilij Grossman osserva come il successo faticosamente strappato dall’Armata Rossa a Stalingrado, pur decisivo nel determinare l’esito del conflitto mondiale, avesse fatalmente innescato un «duello silenzioso tra popolo e Stato, entrambi vittoriosi», destinato a dilatarsi nell’immediato dopoguerra. Sembrava infatti assai verosimile che le masse mobilitate in extremis da Stalin con il celebre appello «Fratelli e sorelle!» avrebbero rivendicato, una volta deposte le armi, un ruolo nella società sovietica più consono allo sforzo bellico sopportato, nonché al sacrificio di vite umane cui si erano piegate, pur di salvare la madrepatria dall’aggressione nazista. «Da quel duello dipendevano il destino dell’uomo, la sua libertà», osserva Grossman, senza tuttavia precisare come l’illusione di una eventuale democratizzazione fosse irrimediabilmente destinata a infrangersi contro l’immagine granitica di uno Stalin ormai utrasessantenne, auto-insignitosi del titolo di «generalissimo» e carico di medaglie, nonché risoluto a volgere a proprio esclusivo vantaggio tutte le implicazioni politiche della vittoria. Tra gli uomini che, da parti diverse del fronte, sarebbero tornati a casa ben oltre la fine delle ostilità, ossia nel corso del 1946, vi erano anche due ufficiali-poeti appartenenti alla medesima generazione che, pur con intonazioni differenti, avrebbero dato voce allo spaesamento del reduce, al suo stupore di fronte a un’umanità che, spossessata di qualsiasi prospettiva di riscatto o palingenesi, aveva già ripreso a girare ossessivamente nella ruota da criceto della vita quotidiana. Incrociando le lame contro lo Stato nel duello evocato da Grossman, il capitano Igor’ Cholin e il maggiore Boris Sluckij avrebbero finito per impersonare due modi opposti di confronto con il potere sovietico: da una parte l’emarginazione volontaria del poeta non ufficiale Cholin che in vita non pubblicò un solo verso, consegnando la propria opera ai rudimentali mezzi di riproduzione del samizdat; dall’altra i tormentosi sdoppiamenti dello scrittore «integrato» Sluckij che suddivise schizofrenicamente la propria opera in testi pubblicabili e altri da destinarsi al cassetto della scrivania, macerandosi tra autocensure, compromessi e rimorsi. Tanto più fortunata è dunque la coincidenza che permette ora al lettore italiano di accostarsi in parallelo a questi due autori nelle edizioni recentemente curate da Alessandro Niero, ovvero l’ampia raccolta di Sluckij Il sesto cielo e le altre poesie (pp. 216, e 18,50, primo tassello di una nuova collana che Passigli dedica alla poesia russa del Novecento) e l’elegante silloge di Cholin, significativamente intitolata Lirica senza lirica (Terra Ferma, pp. 128, e 15,00). Un dittico che, snodandosi dal fronte fino alle retrovie ideologiche del mondo civile, testimonia la ricerca di uno stile più aderente al vero e il tentativo di riflettere quella «vita agra» che attendeva i reduci al ritorno in una lingua scabra, refrattaria e ogni abbellimento retorico. L’imperativo a narrare «ciò che è stato», senza nulla omettere né edulcorare, fu percepito da Sluckij ancor prima che come un dovere morale, come un destino iscritto nelle stesse funzioni da lui assolte al fronte, quelle di istruttore politico. Un compito che costringeva il giovane comunista, mentre combatteva sui campi della natia Ucraina, a confrontarsi quotidianamente con lo scoramento che si andava impadronendo dei soldati, nonché con la capacità innata della guerra di frantumare e confondere «sia ciò che per un uomo è bene / sia ciò che per un uomo è male». Di fronte a quell’indistinto «tritume» cui l’esperienza bellica ha ridotto le vite degli altri, il poeta non può che ascoltare e fissare su carta le loro confessioni, pur consapevole che quelle «verità da vecchi», scoperte prematuramente, lo tormenteranno in eterno: « È il mondo a dettarmi. A notte, fino all’alba, / non scrivo, ma trascrivo. / Io non compongo , espongo storie vere…» Così come graverà su di lui sia la responsabilità di aver fatto fucilare uomini al fronte in quanto disertori, sia la consapevolezza di essersi spesso autocensurato, in ossequio al partito o per ambizione personale. Pur rifuggendo istintivamente dalle vulgate ufficiali (significativa a questo proposito è la poesia che dà il titolo alla raccolta, in cui Sluckij dichiara ironicamente di essere asceso, in quanto ufficiale dell’Armata Rossa, «solo» al «sesto cielo» della presa di Berlino e, non al «settimo cielo» dell’epica imbastita dal potere intorno a tale battaglia), il poeta di origine ebraica ammise di non essere estraneo né a quel processo di lakirovka dejstvitel’nosti («imbellettatura della realtà») cui Stalin incoraggiava gli artisti, né al linciaggio collettivo cui veniva sottoposto chi non si prestava a simili compromessi. Basti ricordare che il 31 ottobre 1958 intervenne alla seduta dell’Unione degli scrittori che decretò l’espulsione di Boris Pasternak all’indomani del conferimento del premio Nobel. Proprio la consapevolezza di essersi piegato supinamente alla disciplina di partito e di essere rimasto «ligio al programma di edificazione» (malgrado a differenza di altri fosse cosciente di star costruendo «sulla sabbia» e non sulla roccia) conferisce all’opera di Sluckij una tragicità tutta particolare, ulteriormente enfatizzata dal suo stile quasi prosastico. Una tonalità destinata ad approfondirsi nei «tempi-non-tempi» della stagnazione, quando il vento della guerra che «sfogliava pagine / di storia universale» si sarà del tutto sopito, e la domanda di libertà alimentata dalla vittoria rimarrà sepolta sotto il peso del conformismo. Ciò che in Sluckij è macigno, rovello interiore e angoscia si trasforma nel quasi coetaneo Cholin in smorfia cinica e fulminante pointe. Effetto forse anche di una biografia a dir poco picaresca che gli fornì il retroterra ideale per diventare il cantore (ovviamente ufficioso) della varia umanità alloggiata nei tetri agglomerati di baracche sorti nel dopoguerra alla periferia di Mosca. Abbandonato dalla madre, il futuro poeta scappò ben presto dall’orfanotrofio cui era stato affidato e trascorse l’infanzia tra i bezprisorniki (ragazzini di strada) finché la viglia del conflitto non prese a frequentare una scuola militare. Benché la guerra si fosse rivelata per lui un’occasione sia pur effimera di ascesa sociale, non si può certo dire che a Cholin fosse sfuggito il suo effetto disumanizzante, almeno a giudicare da questi versi: «La trincea come una biscia / Per il pendio della collina / Striscia / Vi / Brulica dentro / Gente ammattita / In cappotti grigi / microbi al microscopio / gente senza volto». Condannato alla residenza coatta nella zona di Lianozovo, Cholin entrò casualmente in contatto – durante un’uscita clandestina dal campo di prigionia – con la cerchia non ufficiale di poeti e artisti che si stava formando intorno alla figura di Evgenij Kropivnickij. Nei suoi versi originalissimi composti all’inizio degli anni Cinquanta, Gli abitanti delle baracche, Cholin crea una sorta di sorprendente Spoon River sovietica (come già notò Gian Piero Piretto), condensando i ritratti dei tanti «morti di bottiglia» (o delle giovani spose sfiorite tra maltrattamenti domestici e gravidanze plurime) in epitaffi post o ante mortem di scarna, singolare efficacia: «Lavorava in un chiosco, vende kvas, / sgrida i figli con voce di basso / e tradisce il marito con Vlas». Epigrammi apparentemente «incolti» che, tuttavia, a uno sguardo più attento rivelano quella stessa fascinazione per l’art brut popolare coltivata sia dai futuristi, sia dai poeti del gruppo Oberiu. E che, soprattutto, gettano una luce inedita sulla vita degli emarginati sovietici degli anni Cinquanta, esclusi sia da quella allora recente, sia da qualsiasi altra vittoria.
Valentina Parisi
Il Manifesto (16 marzo 2014)

